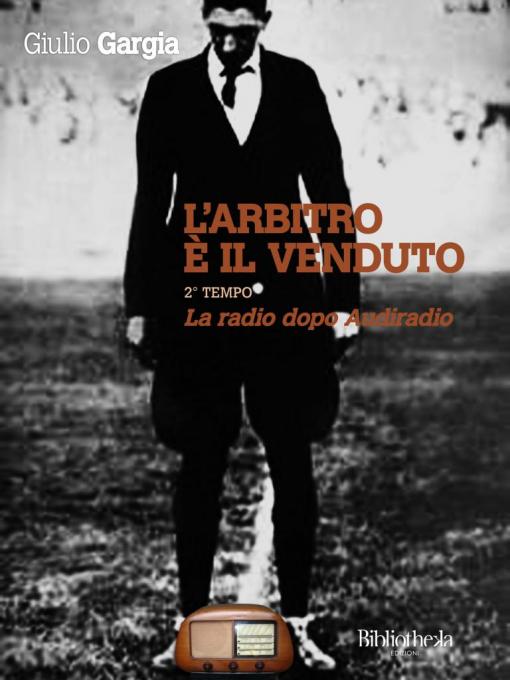Main menu
You are here
Quel ragazzaccio della Via Gluck si divertiva a giocare con noi
di Ugo G. Caruso
fondatore del Movimento Telesaudadista*
Alla fine le molle hanno ceduto sotto il peso delle troppe cazzate dette e il Molleggiato è finito col culo per terra trascinandosi appresso tutto il festival.
A dire il vero, era già decenni che Sanremo sopravviveva artificiosamente, a tutti i costi, alla sua idea originaria di rassegna della canzone italiana e, per rimanere in metafora, l'intelaiatura, usurata un bel pò, emetteva un cigolio fastidioso e persistente. Ma quest'anno più che mai è stata da tutti percepita la dissonanza con l'atmosfera ancora incerta, confusa, contraddittoria ma certamente molto diversa dal passato che si respira nel paese per effetto del perdurante vuoto politico e della grave recessione economica.
Non mi riferisco, sia chiaro, allo sfarzo di per sé. Sono alieno da fondamentalismi d'ogni sorta, compreso quello di matrice cattocomunista ancora pervicacemente diffusa nella mentalità corrente. Pure i musical di Vincente Minnelli e di Stanley Donen erano sontuosi. Ma con ben altri risultati. Ciò che infastidisce di più è la debordanza di Sanremo nell'attenzione mediatica a dispetto della sua pochezza e dello scarso gradimento collettivo, lo straripamento prima, durante e dopo negli insulsi talk show televisivi di tutte le fasce orarie. Anche quei critici che invariabilmente ne scrivono male da anni finiscono poi coll’aderire oggettivamente alla grande macchina propagandistica sanremese, ciascuno col suo contributo, anche quando propugnano la tesi estrema di un salvifico black out televisivo. Ci sarebbe poco da aggiungere alla lista delle nequizie rilevate, seppur ambiguamente, dai tanti innocui detrattori di ruolo: la pacchiana fastosità dell’insieme, le invadenti scenografie space style, le interviste imbarazzanti, le prestazioni senz’anima dei super ospiti ingaggiati per rendere omaggio alla canzone italiana, poi regolarmente implorati affinché intonassero i loro hit come da contratto. Spesso le vedettes in questione mostravano di ignorare bellamente i brani che avrebbero interpretato, un vero e proprio autogol da parte dei retori del patrimonio canzonettistico nazional-popolare. Per non dire dei concorrenti di Sanremo Giovani, tanto vezzeggiati e incoraggiati, che pur avendo indicato Celentano come un maestro, non sanno poi citare neanche un titolo del suo sterminato repertorio, neppure Il ragazzo della Via Gluck o Azzurro. Forse è la sua carriera ad essere presa come punto di riferimento, non avendo loro, per lo più, alcuna passione o legame profondo con la musica. Questa generazione di aspiranti artisti non è disposta a farsi le ossa in cantine e locali underground, in attesa di essere notati da un agente, come avviene in America o in Inghilterra. La loro unica motivazione è quella del successo personale, intossicati dall’ideologia che ispira i talent show. A conferma della palese autoreferenzialità di marca smaccatamente televisiva che separa Sanremo dal mondo della musica basterebbe considerare che neanche una parola è stata spesa per ricordare le recenti e premature scomparse di Ami Winehouse e di Witney Houston. A chi obietta che Sanremo è pur sempre la vetrina della canzone italiana e non internazionale, farei notare allora un’omissione ancora più sorprendente. Appartengo a quella generazione che nell’infanzia teneva spontaneamente per Gianni Morandi a Canzonissima contro Claudio Villa, ultimo paladino dell’italico bel canto, sostenuto dalla platea degli adulti, a quei tempi in genere più tradizionalista. Possibile che l’eterno ragazzo di Monghidoro si sia completamente dimenticato di rendere il giusto tributo all’antico avversario nel venticinquennale della morte? C’è poi la solita questione femminile. Non si tratta di essere femminista nel confessare di essere stufo della contrapposizione tra le due vallette, le stesse dello scorso anno. Il confronto l’ha vinto stavolta Belen che con il suo tatuaggio inguinale ha fatto sussultare i tanti belin dell’Ariston e a casa e francamente anche me che l’ho vista solo sul giornale. Infatti, a differenza di un libro o di un film di cui si può parlare solo dopo averlo letto o visto, Sanremo proprio per la sua totale mancanza di senso può essere comunque oggetto di fondata dissertazione. Mi sono chiesto come si possa ostentare la farfalla-simbolo della Rai pur accompagnandosi a Fabrizio Corona indicato da Berlusconi come uno dei suoi più ascoltati consiglieri. E forse la prova inconfutabile dell’ormai radicato consociativismo Rai- Mediaset? Il mio gusto, va da sé, risente degli anni ormai lontani in cui si è formato. Allora designare il presentatore non era una questione di stato, né questi era una sorta di direttore artistico costretto a considerare mille varianti, evitando di scompiacere una qualsiasi delle tante entità coinvolte nel mega evento. Di solito a condurre le tre canoniche serate bastavano un Daniele Piombi o un Nuccio Costa nel loro smoking d’ordinanza quando non si volevano scomodare un Mike Bongiorno o un Corrado o addirittura strafare avvalendosi di outsiders come Enrico Maria Salerno e Carlo Giuffrè. Ad affiancarli c’era sempre una presenza femminile piuttosto frizzante che poteva variare da Luisa Rivelli a Grazia Maria Spina, fattesi notare in qualche teleromanzo giallo della serie del Tenente Sheridan. Ci piaceva Sanremo quando tutti o quasi i telespettatori, anche quelli apparentemente più disinteressati, si dividevano per Little Tony e Bobby Solo, Gigliola Cinquetti e Caterina Caselli, Wilma Goich e Iva Zanicchi, Patty Pravo e Sergio Endrigo. Erano gli anni in cui grandi interpreti internazionali come Gene Pitney e Dionne Warwick, Stevie Wonder e Sandie Shaw, Nino Ferrer e Antoine entravano in lizza accanto ai nostri beniamini nazionali senza essere piedistallizzati per il solo fatto di cantare in un’altra lingua. Allora ancor più che alla radio le canzoni venivano riverberate dalla gente nei bar e per strada, nei bus e negli uffici, divenendo nel giro di poche settimane un patrimonio comune e duraturo. Poteva capitare di vedere Louis Armstrong sul palcoscenico del Casinò prodursi in un assolo di tromba fuori dalla durata standard dell’esibizione oppure ascoltare Lionel Hampton rifare i motivi in gara col suono meraviglioso del suo vibrafono. Anche Gianni Mura che ha l’età per ricordare le edizioni degli anni cinquanta dominate da Nilla Pizzi e Giorgio Consolini, Carla Boni e Gino Latilla, Luciano Tajoli e Claudio Villa, domenica scorsa confessava su Repubblica la sua insofferenza per Sanremo e tutta la televisione di oggi, preferendogli di gran lunga Gorni Kramer e Il Musichiere, Delia Scala e Lauretta Masiero, Alberto Manzi e Alberto Lupo. Ma non è solo una questione anagrafica che ci ha fatto fissare certi parametri estetici basati sull’essenzialità, la sobrietà e l’eleganza. A dirla tutta, Sanremo non è mai stato esattamente uno specchio dell’Italia, è rimasto sempre un passo dietro, lesinando spazi alle correnti e agli interpreti più innovativi. Ma dietro un’apparenza modaiola e à la page, quando non addirittura finto trendy, è rimasta sempre più indietro, finanche quando negli ultimi anni è stato l’intero paese a segnare il passo. Sanremo rimane un fenomeno italianissimo, un paradigma atemporale dell’Italia stessa. Nei primi anni sessanta in Brasile si tentò di esportarne l’esperimento coinvolgendo artisti come Gilberto Gil o Egberto Gismonti che avrebbero preso poi strade molto diverse. Nel nostro paese invece la sempiterneità di Sanremo rifletterà l’immobilismo italiano, quello dell’unica nazione europea incapace di cambiare democraticamente classe dirigente, confermando per quasi cinquant’anni la Democrazia Cristiana per poi passare al discontinuo quindicennio berlusconiano e ritrovandosi con una sinistra tenue, fiacca, divisa e senza idee. Sanremo non è più l’ingenua evasione dal sociale che fu nei primi decenni. Lo testimonia la platea dell’Ariston di semivip entrati col biglietto omaggio, pronti ad applaudire non il talento ma il successo e disposti a sostenere quanti esprimono dal palcoscenico un qualsiasi dissenso, pur sempre super pagato, s’intende ma al contempo, come scriveva Francesco Merlo, fanno l’occhiolino a chi detiene il potere. Poi c’è l’immensa platea domestica, vasta, eterogenea, refrattaria a facili categorizzazioni sociologiche. Eppure chissà quanti tra coloro che hanno seguito anche questa dodicesima, immemorabile edizione, sentiranno in cuor loro di tenere a sinistra, pur essendo incapaci di cambiare canale o ancora meglio, per quanti ne avevano la possibilità, di trascorrere fuori il sabato, magari ascoltando un buon concerto oppure un film o uno spettacolo teatrale, servendo così la causa della cultura, quella che non dà da mangiare secondo l’ex ministro Tremonti. Il festival riflette l’apatia, la passività, l’inerzia di un paese incapace di rinnovarsi, cominciando col sottrarsi a riti frusti e svuotati di significato. Rispetto alle edizioni scorse quest’ultima è stata segnata dal paradosso della provocazione commissionata, contrattualizzata e profumatamente remunerata ( chi ci dice la Rai non avrebbe potuto spendere meglio la stessa somma rispetto alle indicazioni fornite da Celentano per il suo cachet devoluto in beneficenza?) poi sconfessata e stigmatizzata. Un po’ come se un tale scegliesse per moglie una donna esperta e vissuta salvo poi rimproverarle una certa sicurezza nell’intimità. Che tipo di provocazione ci si poteva aspettare dal “ re degli ignoranti”? Un’eresia degna di Christopher Hitchens o Michel Houellebecq? No, una meschina ripicca contro l’Avvenire e Famiglia Cristiana, rei in realtà di averlo criticato in passato ma attaccati, come tutti sappiamo, in quanto più propensi a scrivere di cose terrene anziché del Paradiso. Nel mirino di Celentano è finito per ragioni analoghe pure il critico Aldo Grasso, semmai empio per noialtri telesaudadisti per aver omesso una voce su Elena Zareschi nella sua garzantina sulla televisione. Nel corso della replica di sabato sera il cantante ha evidenziato la sfumatura secondo la quale i suddetti giornali andrebbero chiusi, usando perciò il condizionale. Ci ha sorpreso, lo confesso, avendoci abituato egli ad una certa disinvoltura sintattica che fece la fortuna di strofe come “ ma a mezzanotte e tre /io non vorrei che tu / stai già pensando ad un altro uomo” in cui non so quanto la rinuncia al congiuntivo sia stata dettata da licenza poetica. Confesso di non aver mai provato simpatia per Adriano Celentano a cui riconosco però essenzialmente due meriti: il primo è quello di aver efficacemente importato e contribuito a diffondere in Italia il rock and roll, anche grazie alle sue clownerie ispirate a Jerry Lewis. Il secondo è quello di averci fatto scoprire come autore Paolo Conte che già nel ‘66 firmava il retro de Il Ragazzo della Via Gluck intitolato significativamente Chi era Lui. Neanche a farlo apposta: Joan Lui versus Lorenza Lei, come in un album speciale della Marvel, tipo She-Hulk contro Elektra. Chi ha memoria di Adriano rammenterà certamente che già nei primi anni sessanta sparava a zero sui Beatles da cui si sentiva superato. Il problema più importante per lui e per i ragazzi del Clan, se ricordate bene, era quello di trovare una ragazza con cui uscire di sera. Anche a volere ammettere una certa rigidità di costumi che angustiava la vita sociale delle giovani italiane, rispetto alle rivendicazioni dei cantanti francesi o anglosassoni coevi appariva davvero una sciocchezza. Eppure, contraddittoriamente, quella vena mistica che iniziava ad affiorare gli faceva tradurre Stand by me - invito di un ragazzo ad una ragazza a trascorrere la notte insieme - nel miracolistico e lacrimoso Pregherò. A Sanremo ’70 vinse poi con quello che apparve a tutti un inno al crumiraggio, Chi non lavora non fa l’amore, decisamente in controtendenza rispetto allo spirito dell’epoca. Si parlò insistentemente di una vittoria contraffatta, decisa a tavolino dall’establishment a discapito de La prima cosa bella, la più votata. Sta di fatto che l’anno successivo la Rca, scuderia del defraudato Nicola Di Bari conquistò nei primi tre posti quasi a mò di indennizzo. Celentano frattanto si sarebbe preso sempre più sul serio con la complicità di registi e produttori cinematografici, dirigenti televisivi, giornalisti e opinionisti molti dei quali militanti nella sinistra. Personalmente ricordo di aver capito nel modo più brusco che qualcosa era cambiato e in peggio quando nel 1988, passeggiando di notte a Roma, nel quartiere San Lorenzo, mi imbattei in una redattrice de L’Unità, che uscendo dal giornale,stravolta per la stanchezza, mi raccontava di aver dovuto ribattere la prima pagina a tarda ora per dare conto della polemica di Celentano in favore delle foche. Pensai ad uno scherzo , doveva trattarsi della vecchia battuta da avanspettacolo “ W la Foca che Dio la benedoca”.Invece no, era proprio vero. Il principale giornale della sinistra italiana aveva ormai capitolato, cadendo anch’esso nella trappola della centralità perversa della televisione. Da allora la carriera di Celentano quale predicatore (in)degno di un romanzo di Flannery O’ Connery, è stata in continua ascesa. Tra le sue millanta e più cazzate di sapore cattolico tradizionalista e ispirate ad un ecologismo facile facile, sempre propinateci attraverso il servizio televisivo pubblico vorrei ricordare soltanto la contrapposizione tra lento e rock, quali categorie dello spirito, forse attinte dal Molleggiato ai due generi ballabili in voga tanti anni prima. Nel tentativo di intercettare un pubblico giovanile il rock veniva identificato con tutto quanto è figo, cool, come direbbero gli americani. Il lento ovviamente è out. Non pretendo che Celentano conosca un testo come La Scoperta della lentezza di Sten Nadolny ma le ragioni che hanno indotto Carlin Petrini a fondare i presidii Slow food non dovrebbero dispiacergli. Mi chiedo infine come mai quando da adolescente ascoltavo e riascoltavo fino a consumarne i solchi i dischi di Traffic, King Crimson, Pink Floyd, Creedence, Jefferson Airplane, perché lui che è tanto rock cantava invece Viola e Sotto le lenzuola? C’è una cosa però che condivido nei telesermoni più o meno recenti di Celentano, l’ invito a spegnere i televisori. A cominciare da quando c’è lui in scena, direi a questo punto. Nel congedarsi a fine festival, Gianni Morandi ricordava ancora una volta ai teleutenti di pagare al più presto il canone Rai. Mi verrebbe da parafrasare una canzone de I Giganti, Proposta, che soffiò una ventata d’aria nuova a Sanremo nel ’67 e di rivolgere a mia volta un contro invito ai telespettatori, “Mettete i canoni nei vostri cannoni e sbriciolateli in tanti coriandoli che tanto è pure Carnevale”.
* Movimento Telesaudadista : corrente di pensiero e sodalizio culturale che ha come fine lo studio e la riproposizione del grande patrimonio televisivo degli anni del bianco e nero.
- Log in to post comments