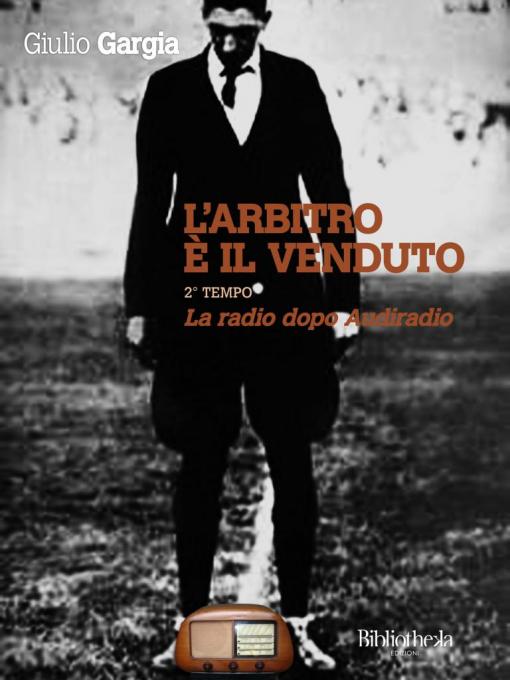Main menu
You are here
Guccini o delle memorabilia dell'anima - di Ugo G. Caruso
Le balere, il cinema in cui si entrava a qualsiasi ora, la naia di diciotto mesi, la maglia di lana, le braghe corte, il ciuffo a banana, il lattaio a domicilio, il postino di campagna, il bigliettaio del tram,
i cantastorie, la ghiacciaia, la carbonella, il flirt, i bagni nel fiume, i treni a vapore, la Topolino, le sigarette sfuse, il caffè d’orzo, i liquori fatti in casa, il telefono duplex, i pennini, i giochi in disuso, i riti di iniziazione alla bicicletta e al ballo. Luoghi, figure, oggetti, alimenti, indumenti, abitudini, passaggi di età che appartengono ad un mondo ormai remoto eppure a noi ancora così prossimo o per ricordi personali o perché continuamente evocati dall’esperienza di quanti più, avanti negli anni, ne furono segnati nel bene e nel male. Cose lontane sempre presenti, insomma.
Le evoca ad una ad una con quel pizzico di inevitabile nostalgia, mescolata però a tanta ironia, Francesco Guccini nel suo Dizionario delle cose perdute, uscito di recente con successo per Mondadori, attingendo ai ricordi della sua infanzia e adolescenza trascorse tra Pavana nell’Appennino Tosco-emiliano, Modena e infine Bologna. La stessa materia che ha ispirato la sua quarantennale produzione di cantautore e più di recente di scrittore, in singolo o in coppia col giallista Loriano Macchiavelli.
La scrittura volutamente semplice, diretta, immediata ricorda più che la parola lavorata delle sue canzoni, Il tono colloquiale con cui Guccini presenta le stesse al pubblico negli intermezzi parlati durante i concerti. E’ come se per la prima volta gli attrezzi di scena che prima apparivano relegati sullo sfondo o che potevano solo essere immaginati, venissero finalmente focalizzati, inquadrati in primo piano assurgendo al ruolo di protagonisti.
Qua e là affiora la vena più crepuscolare e malinconica, quella gozzaniana per intenderci, cui si può ricondurre la geniale sinestesia di “stoviglie color nostalgia” in Incontro. Più spesso lo spirito che anima le pagine è quello umoristico che pervade un disco come Opera buffa, lo stesso condiviso a lungo con Bonvi di cui resta esempio indimenticabile il carosello della Doria della serie Salomone pirata pacioccone. Si tratta di aneddoti, bozzetti, macchiette, racconti paradossali di vita vissuta o inventata buoni per tirar tardi in osteria con agli amici in una notte d’estate.
Oltre alle storie intorno alla naia incombente basterebbe pensare al mondo dei dancing, dei locali di provincia in cui dal dopoguerra fino ai primi anni sessanta si ballavano boogie woogie, rumba, mambo, chachacha fino all’irrompere dei primi ancora timidi rock and roll, quegli ambienti visti tante volte nei film di Pupi Avati, gli stessi frequentati dal giovane clarinettista Lucio Dalla sulle orme di Hengel Gualdi o dal simpatico Andrea Mingardi che li ha raccontati pure in un libro gustoso come Permette un ballo signorina?. Mentre ripassiamo l’elenco di invisibili memorabilia dell'anima, ci sembra di risentire note e versi ascoltati tante volte “ fra giochi consumati dietro al Florida” oppure “ le donne treman quando monto la Gilera/ fremono aspettando alla balera” o anche “ in fondo alla strada si è accesa l’insegna Blue Garden: si balla….canterà Baby Silver”.
C’e’ insomma l’universo gucciniano nella sua integralità ma rispetto a quello più urbano, modenese e bolognese, prevale quello rurale, arcaico, legato ai cicli della terra e delle stagioni, un mondo contadino ancora distante dal benessere e da un consumismo di là da venire (“io la montagna nel cuore scoprivo l’odore del dopoguerra”).
E’ curioso, proprio a voler essere pignoli, che l’autore abbia trascurato una figura centrale della vita e del tempo così particolareggiatamente evocati nel suo dizionario, quella ormai quasi del tutto scomparsa della azdora, come direbbero in Romagna, o della rezdora, secondo l’uso emiliano, ovvero della massaia, la governante dell’economia domestica, la reggitrice del desco familiare all’interno della “famiglia allargata”, così come era intesa allora in un’ accezione ben diversa da quella odierna. A quell’ antica tradizione emiliana si rifanno le poche sfogline superstiti che hanno ereditato l’arte di tirar su la sfoglia rigorosamente a mano aiutandosi col mattarello, preferibilmente di ciliegio.
A questo punto ancor più del gnocco fritto, della mortadella o del culatello, sarebbe stato giusto e nientaffatto scontato ricordare il tortellino di una volta fatto in casa, turteléin in bolognese o se preferite turtléin in modenese, perfettamente rotondo, tonico e spiraliforme, a somiglianza dell’ombelico di Venere, come vuole la leggenda. Meritava forse nella memoria gucciniana e in quella collettiva emiliana il ruolo di contraltare rustico e salato della madeleine di Angelina celebrata da Proust.
Ugo G. Caruso
- Log in to post comments