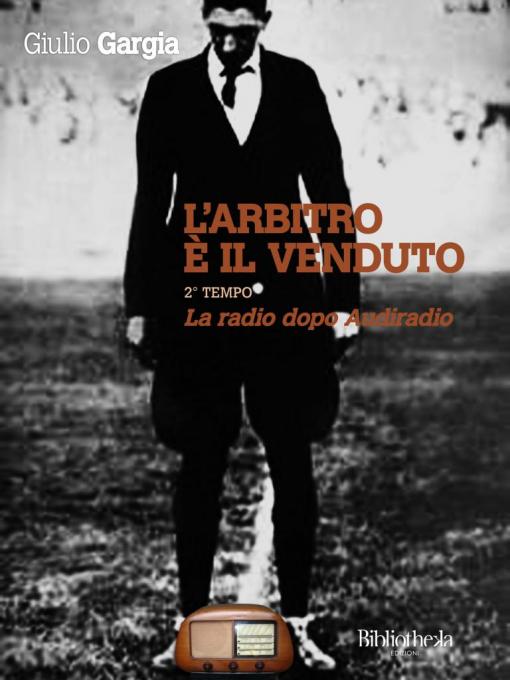Main menu
You are here
“La mia classe”, sul set con gli immigrati
Dare voce e visione ai nuovi soggetti e schermi della trasmigrazione cinematografica
di Riccardo Tavani
Dare voce a chi non ce l’ha, a chi è tolta, a chi non sa o viene impedito di esprimersi. Dare voce ha il senso di dare o ridare una possibilità, una chance storica, sociale a chi viene o è stata negata. Questo, secondo Walter Benjamin, è lo strato più autentico che è al fondamento di ogni arte e che ogni singola opera dovrebbe essere capace di far riemergere. In questo film questo dare voce, in quanto possibilità, assume una duplice faccia: cinematografica e civile. C’è, infatti, da una parte, un produttore, Gianluca Arcopinto della Pablo, il quale non è nuovo a dare una possibilità di espressione a progetti, idee di cinema che esulano dalle vie canoniche. Dall’altra, due sceneggiatori, Claudia Russo e Gino Clemente, che insieme a un regista, Daniele Gaglianone, danno voce a un gruppo di immigrati, provenienti da diversi punti del pianeta. Dare voce qui significa letteralmente offrire loro la possibilità di esprimere pensieri e sentimenti nella lingua del Paese nel quale sono approdati, l’Italia.
Claudia Russo, oltre a quello di sceneggiatrice, fa anche il lavoro di insegnante di italiano per immigrati in una scuola periferica di Roma. L’idea originaria del film è stata sua. Dal copione che ne scaturisce si passa alla ricerca del variegato gruppo di trasmigranti che comporranno la classe di studenti, poi alla troupe per le riprese. Qui il progetto iniziale cambia inaspettatamente pelle, trasmigra, trasmuta in altro. Tutto perché uno degli immigrati selezionati è colpito da decreto di espulsione e non più legalmente lavorare sul set (e neanche altrove). Il film si fa allora non più pura fiction ma neanche reale docu-fiction. Qualcosa di diverso, non facilmente catalogabile. Ai partecipanti è spiegato che l’attore Valerio Mastandrea sarà il loro maestro di italiano, ma essi saranno attori solo di se stessi, senza copione, se non quello di ciò che pensano e sentono. Anche Mastrandea, in realtà, è costretto poi ad improvvisare, ad adattarsi alle situazioni che si determinano spontaneamente sulla scena, ovvero tra i banchi di quella classe, e dimostra di saperlo fare egregiamente.
Si è detto che il film, insieme ai convincenti e coinvolgenti momenti di autenticità, sconta anche i difetti, gli intoppi di un simile meccanismo narrativo, che non nasconde, ma semmai mette bene in mostra l’intervento della troupe e del regista in alcune scene cruciali. Può essere anche vero, ma non si tiene conte dell’alto valore di attiva sperimentazione sul campo che un film come questo rappresenta in un momento di cambiamento profondo, anzi, di trasmigrazione semantica dell’espressione cinematografica. Trasmigrazione dovuta all’irruzione di nuovi media elettronici come telefoni mobili, tablet, macchine fotografiche in grado di riprendere, montare e mettere direttamente sul web, e insieme di trasmutare i canoni espressivi.
Gianluca Arcopinto sarà anche un produttore minore, con disponibilità ridotte di budget, ma non lo è certamente nella visione del cinema, perché anzi si dimostra all’avanguardia più di molti altri. La struttura sperimentale di questo film, inoltre, non diminuisce affatto il gradimento, la partecipazione emotiva del pubblico alle vicende, alle situazioni che scorrono sullo schermo, anzi! Si è deciso, alla stessa stregua, che il film non abbia neanche una distribuzione canonica nelle sale. Si punta tutto sulla richiesta diretta, sul passaparola, sulla connettività e convergenza degli spettatori a dare voce, visione - in prima persona e insieme - al loro nuovo cinema e ai suoi nuovi soggetti.
- Log in to post comments